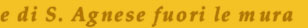La basilica onoriana di S. Agnese
 L'attuale
chiesa di S. Agnese è il frutto di una serie di
trasformazioni e restauri - succedutisi nei secoli - di
una basilica fatta realizzare da papa Onorio
I (625-638), di cui ancora oggi conserva gran parte
dei caratteri.
L'attuale
chiesa di S. Agnese è il frutto di una serie di
trasformazioni e restauri - succedutisi nei secoli - di
una basilica fatta realizzare da papa Onorio
I (625-638), di cui ancora oggi conserva gran parte
dei caratteri.
Onorio I è da collocare storicamente tra i continuatori dell'opera di Gregorio Magno, il pontefice che - sulla scia dell'inefficiente amministrazione bizantina - diede l'avvio ad una gestione diretta del potere temporale da parte della Chiesa. Rispetto a Gregorio, che si dedicò principalmente a salvaguardare dalle invasioni Roma ed i possedimenti della Chiesa, Onorio fu particolarmente attivo in ambito edilizio, lasciando tracce in tutta la città, specialmente con i restauri delle chiese esistenti, tra cui S. Pietro.
Ecco la situazione sulla quale intervenne Onorio. La giovane martire Agnese era stata sepolta in una galleria al primo piano del cimitero sotterraneo sulla via Nomentana (le catacombe). Lo sviluppo del culto derivante dal suo martirio - che vide tra i più convinti adepti proprio la principessa Costantina - portò alla realizzazione di un sacello "ad corpus" semi interrato sul fianco della collina, contestualmente all'edificazione della grande basilica cimiteriale costantiniana. La costruzione del sacello fu necessaria, perché la Chiesa romana proibiva di manomettere i luoghi di sepoltura, per prevenire la dispersione delle reliquie.
Per realizzare la basilica, gli architetti di Onorio ripresero un modello introdotto mezzo secolo prima da papa Pelagio II (579-590), con la costruzione della basilica di S. Lorenzo fuori le Mura. In una situazione molto simile a quella dell'area di S. Agnese, con:
- la presenza di una basilica cimiteriale semi-abbandonata;
- il corpo del santo sepolto in una catacomba, che poneva molti limiti all'accesso dei pellegrini;
- la volontà di non rimuovere il corpo oggetto di venerazione;
- la necessità di favorire l'afflusso di pellegrini nella città, i quali costituivano una risorsa irrinunciabile in un periodo caratterizzato da grande incertezza.
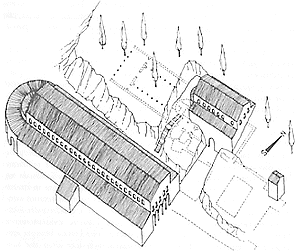
A sinistra, ricostruzione (W. Frankl) del complesso di S. Lorenzo fuori le mura (da Krautheimer, 1981)
A S. Lorenzo fu adottata una soluzione particolarmente ingegnosa, ripresa piuttosto fedelmente a S. Agnese. Fu realizzata una basilica seminterrata, in modo che il pavimento fosse al livello della tomba oggetto di culto, sbancando parte della collina. A S. Lorenzo l'ingresso avveniva lateralmente, mentre a S. Agnese ci si arrivava per mezzo di una scala (come tuttora avviene, per chi accede dalla Via Nomentana). Al livello superiore, in entrambe le basiliche, fu realizzata una galleria che correva su tre lati: in corrispondenza delle due navate laterali e del nartece, che era interno. La galleria consentiva di accedere all'interno della basilica anche a chi non era in grado di percorrere le scale; inoltre permetteva di avere spazio aggiuntivo nei giorni di particolare afflusso.
 A
S. Agnese emergevano quindi dalla sommità della
collina solo il cleristorio e le gallerie, con un effetto
simile a quello che ci hanno trasmesso fotografie di epoche
precedenti l'urbanizzazione della zona. Le opere di
sterro che portarono alla realizzazione della facciata
principale, con le tre attuali porte d'ingresso, furono
realizzate solamente nel 1600, dal cardinale Alessandro
Ottaviano de' Medici.
A
S. Agnese emergevano quindi dalla sommità della
collina solo il cleristorio e le gallerie, con un effetto
simile a quello che ci hanno trasmesso fotografie di epoche
precedenti l'urbanizzazione della zona. Le opere di
sterro che portarono alla realizzazione della facciata
principale, con le tre attuali porte d'ingresso, furono
realizzate solamente nel 1600, dal cardinale Alessandro
Ottaviano de' Medici.
Coevo alla costruzione della basilica è il grande mosaico che copre l'intero catino absidale, raffigurante S. Agnese, la quale ha ai piedi le fiamme e la spada del martirio, ed è affiancata dai papi Simmaco e Onorio, quest'ultimo che reca in mano il modellino della chiesa. La sottostante parete dell'abside, decorata con paraste e trabeazione in porfido, ci ha lasciato una testimonianza dello stile semplice ma monumentale di questo edificio.

 Tutte
le colonne utilizzate all'interno della basilica
sono di spoglio, cioè ricavate da edifici
romani andati in rovina, probabilmente la limitrofa stessa
basilica costantiniana. La varietà dei fusti e
dei capitelli - derivante dalla loro origine - è
stata sapientemente sfruttata dall'architetto per conferire
dinamismo all'edificio, segnando in particolare
la progressione del percorso che il pellegrino
avrebbe compiuto in direzione dell'altare che custodiva
il corpo della venerata Agnese.
Tutte
le colonne utilizzate all'interno della basilica
sono di spoglio, cioè ricavate da edifici
romani andati in rovina, probabilmente la limitrofa stessa
basilica costantiniana. La varietà dei fusti e
dei capitelli - derivante dalla loro origine - è
stata sapientemente sfruttata dall'architetto per conferire
dinamismo all'edificio, segnando in particolare
la progressione del percorso che il pellegrino
avrebbe compiuto in direzione dell'altare che custodiva
il corpo della venerata Agnese.
Delle 16 colonne che circondano l'aula centrale, le prime due coppie, verso l'altare, sono di marmo pregiato di portasanta, le successive, scanalate, di paonazzetto. Poi 4 coppie di bigio precciato ed infine - a separare la bavata dal nartece - due colonne di granito nero. Tutte le colonne hanno raffinati capitelli corinzi classici, ad eccezione di quelle di portasanta, dotate di più grezzi capitelli del VII secolo.
Nei secoli seguenti la basilica ha subito profondi cambiamenti:
- nel XV secolo le navate laterali, originariamente dotate di soffitto, furono ricoperte con le attuali volte a crociera;
- nel 1606 il cardinale Paolo Emilio Sfondrati, per coprire le capriate a vista del tetto, fece realizzare il soffitto a lacunari, che ancora oggi possiamo ammirare, seppure nella colorazione conferitagli dall’intervento ordinato da Pio IX nel 1855;
- tra il 1609 e il 1881 furono aggiunte le 6 cappelle laterali; l’edificio originale, infatti, ne era privo, anche perché le cappelle - come corpi aggiunti agli edifici ecclesiastici - cominciarono a diffondersi solo a partire dal X secolo;
- le coperture del matroneo, inizialmente a tetto spiovente, furono munite di soffitto tra il XVI e il XVII secolo, e poi - nel 1855 - di volte a crociera;
- attorno al 1620 Paolo V dotò la basilica di un nuovo altare, tuttora esistente, riccamente decorato nei suoi quattro lati da un intarsio di pietre e marmi preziosi, sormontandolo con un bel ciborio, sostenuto da quattro colonnine di porfido;
- il pavimento musivo di tipo cosmatesco della navata centrale, ammirato per il suo splendore e descritto da autori del XVI secolo, fu sostituito nel 1728 da un impiantito di mattoni, il quale nel 1855-56 fu a sua volta rimpiazzato da un pavimento fatto realizzare da Pio IX con i marmi avanzati dal nuovo pavimento della basilica di S. Paolo;
- l’interno della basilica fu ornato di pitture nei secoli XII/XIII, XIV, XVII e XIX; gli affreschi medievali sono andati quasi del tutto perduti, soprattutto a causa dei lavori del XVII secolo, ma l’attuale aspetto della basilica è determinato quasi interamente dalle pitture fatte realizzare attorno al 1856 dal papa PIO IX.
 L’aspetto
della basilica, dunque, è molto cambiato
dai tempi della primitiva costruzione Onoriana, soprattutto
a causa delle decorazioni ottocentesche, che oggi sono
predominanti nella percezione visiva, dei diversi trattamenti
riservati ai soffitti e della scomparsa del pavimento
cosmatesco.
L’aspetto
della basilica, dunque, è molto cambiato
dai tempi della primitiva costruzione Onoriana, soprattutto
a causa delle decorazioni ottocentesche, che oggi sono
predominanti nella percezione visiva, dei diversi trattamenti
riservati ai soffitti e della scomparsa del pavimento
cosmatesco.
La stessa presenza del ciborio svolge un ruolo
determinante, sotto questo profilo.
Sono del resto estremamente rari i casi di edifici che hanno attraversato intatti i secoli, per giungere a noi nelle forme concepite dai loro primi architetti. Concepire l’architettura come un processo vitale, che consente alla storia di lasciare tracce di sé negli edifici, aiuterà certamente nella comprensione di questo splendido manufatto.